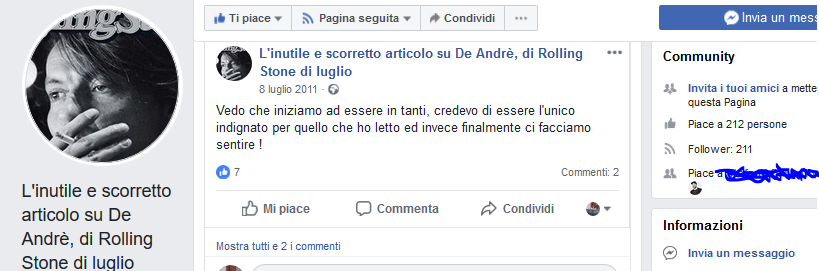 Questo pezzo, oggi introvabile ma a suo tempo relativamente discusso e oggetto di (comprensibili) polemiche, e di plausi in realtà non proprio edificanti (da parte di testate che non apprezzo affatto) mi venne proposto dal direttore di un mensile che potete cercare di indovinare. Lascerò qualche indizio.
Questo pezzo, oggi introvabile ma a suo tempo relativamente discusso e oggetto di (comprensibili) polemiche, e di plausi in realtà non proprio edificanti (da parte di testate che non apprezzo affatto) mi venne proposto dal direttore di un mensile che potete cercare di indovinare. Lascerò qualche indizio.
Non c’era ancora stata la fiction Rai su De André, ma la santificazione era già in atto da un bel po’. Credo di essere stato abbastanza onesto nel mettere insieme le dichiarazioni rilasciate dall’artista medesimo, evidenziando qualche contraddizione. Ma so che oggi non lo scriverei allo stesso modo. Perché se l’appropriazione di De André è giunta al suo picco di ridicolo nella aperta (e forse non completamente simulata) venerazione da parte del ministroduce, che ha finito per prendere il potere grazie al sempre vivo servilismo fascista di questo popolo, vuol dire che qualcosa è andato storto.  Questo perché nonostante le sue contraddizioni personali (che oggi rivaluto, perché paradossalmente rendono giustizia alla sua poetica più di quanto avessi notato all’epoca dell’articolo) non ho dubbi che De André oggi stralunerebbe senza contraddizione alcuna, sapendo di avere come estimatore il più smaccato opportunista mai andato al potere in Italia
Questo perché nonostante le sue contraddizioni personali (che oggi rivaluto, perché paradossalmente rendono giustizia alla sua poetica più di quanto avessi notato all’epoca dell’articolo) non ho dubbi che De André oggi stralunerebbe senza contraddizione alcuna, sapendo di avere come estimatore il più smaccato opportunista mai andato al potere in Italia
(…e scorrendo la lista di chi lo ha preceduto, è un risultato di tutto rispetto).
E anche se la parte sull’appropriazione nell’articolo c’è, sui veri motivi per i quali De André sia così manipolabile non ho scavato abbastanza. E dire che bastava guardare nella direzione più facile, quella della religione – mai anarchico l’ha cantata con altrettanto interesse. Evidentemente, si stava preparando al suo destino di santo.
Detto questo, ecco il famoso articolo.
Beatificazioni. In Italia ne sappiamo qualcosa. Così come di gratuite iconoclastie.
Atteggiamenti non molto utili, detto sinceramente, però altrettanto sinceramente ammettiamo che in questa sede ci proponiamo di riesaminare la figura di Fabrizio De André con la maggiore onestà possibile per evitare che il suo culto continui a scivolare lungo una piega pericolosamente acritica, perché la Leggenda del Santo Cantautore non sarebbe piaciuta a lui per primo. Ma non ci interessa tanto tirarlo giù dal piedistallo, che sarebbe un atto autenticamente deandreiano – quanto avvicinarlo per capire in cosa, davvero, è stato grande. Se poi incorreremo in blasfemia, ce ne scusiamo, invitandovi a trovare conferma delle virtù del cantautore genovese nei mille omaggi cantati, nei programmi tv, in decine di saggi e biografie: vangeli apocrifi di un artista che sta venendo svuotato nel modo più subdolo: con la santificazione.
Partiamo da tre nomi. Hendrix, Joplin, Morrison.
Chi legge Rolling Stone dovrebbe sapere a cosa alludiamo – ma proviamo a rilanciare con una triade italiana: Mina, Battisti, De André.
Qui la morte non c’entra, e non solo perché Mina è ancora tra noi, ma perché i tre sono stati mito e caposcuola già in vita (insieme a Celentano. Gli altri, anche chi ha magari venduto persino di più, o fatto cose comunque eccelse, non sono muri portanti dell’edificio).
Tutti e tre giunti al mito tramite un’altra, affascinante forma di scomparsa: quella dal pubblico. E parliamo di scomparsa volontaria, non di perdita del successo, il flop rovinoso che delizia i media quanto le genti. Non è facile far capire oggi quanto tale scelta, a metà anni 70, sconvolgesse questo Paese. Tenendo conto poi che in Italia i tre nomi succitati avevano una popolarità di massa che in USA le tre J non avevano. Il caso di De André è il più eclatante. Perché fu sottratto al pubblico non una, ma tre volte. 
La prima, per scelta. Rileggendo i giornali d’epoca, si evince che la cosa faceva impazzire i media. Due esempi: nel 1971 l’Intrepido, popolarissimo settimanale a fumetti, gli dedicò alcune tavole beffarde in rima (una diceva: “Or fa il timido e lo schivo, si dà arie di anti-divo, non partecipa a serate, teme forse le patate?). Nel 1978, sul Messaggero, Dario Salvatori scriveva: «In tempi di spettacolo totale è difficile comprendere le scelte di un uomo che usa i canali di una professione pubblica senza correre il rischio dell’esposizione. Diciamo pure una scelta furbesca, antipatica, fatta a tavolino…».
Ma si badi: De André cercava di evitare i concerti per (dichiarato) disagio nei confronti del pubblico, ma non si negava ad alcun giornale: concedeva interviste alle testate più incredibili e variegate (con buona pace di certi immensi artisti contemporanei da mille cd venduti, le cui preziose minchiate gli uffici stampa concedono solo a papà Corriere, mamma Repubblica e zia Vanity). Smentendo il frizzantello Salvatori, proprio alla fine del 1978 De André si espose, nel celebre tour con la Pfm. Qualche mese dopo la fine della tournée, fu però sottratto al pubblico per la seconda volta, sequestrato da banditi in Sardegna, per quattro mesi. 
Vent’anni dopo la terrificante esperienza, nell’estate del 1998, un De André molto mutato dal punto di vista personale e artistico interruppe un tour dopo un anno e mezzo denso di concerti, per la malattia che nel gennaio del 1999 lo sottrasse per la terza volta al pubblico. Al momento della dipartita, il lutto non fu paragonabile a quello che aveva attraversato la nazione alla morte del più popolare (nei vari sensi del termine) Lucio Battisti – tenete a mente questo nome, lo risentirete. Ma col tempo, è stato un crescendo. Oggi, nessuno in Italia gode della reverenza tributata a Fabrizio De André. E’ una gara a chi meglio lo rievoca, rilegge, cita, analizza, svela… e canta.
«Ognuno ha il suo De André», dice Eugenio Finardi, che lo conobbe bene, «ed è giusto così».
Nel coro, poche voci controcorrente. Su tutte, una è particolarmente riconoscibile. Quella di Fabrizio De André. Che per anni ribadì: «Sono un bene di consumo, ormai è il mio mestiere. Raggiunto il mio stile mi sono un po’ fossilizzato. Se la gente vuole questo, non vedo perché non darglielo». (Amica, 1971) «Con una fava pigliavamo più piccioni: facevamo gli scapigliati, i colti, i demistificatori, i protestatori, dicevamo la parola puttana in una canzone, lasciando poi intendere che conoscevamo la musica antica e la Storia (…) Sono un piccolo borghese e faccio canzoni solo per guadagnare». (L’Unità, 1978)
Lucido nell’autocritica, ma confuso in politica. Oltre a spargere ovunque il concetto – e lo status – di “piccolo borghese” come fosse la tana che libera tutti, che giustifica ogni cosa («Mai stato un rivoluzionario, combatterei per i cioccolatini, per il superfluo come tutti i borghesi») inciampò in uscite impopolari, come «Nella scuola pubblica mio figlio si scontrerebbe con la società reale e le sue contraddizioni, ma nella scuola privata può studiare più tranquillo e ottenere tutti gli strumenti che gli saranno necessari per sopravvivere in un mondo che diventerà un ordinato nazismo» (Domenica del Corriere, 1974). Il suo concept album politicamente impegnato Storia di un impiegato peraltro non andò a buon fine: dopo aver detto che era il suo disco più onesto, al contrario di «Spoon River, commerciale e scontato», di fronte agli attacchi della critica militante ci ripensò: «Era la prima volta che mi dichiaravo politicamente e so di non esser riuscito a spiegarmi. Quando è uscito volevo bruciare il disco». Ma dopo l’album “anarco-insurrezionalista”, anche un’iniziativa opposta ebbe reazioni acide: l’esibizione del 1975 per il pubblico chic della Bussola di Sergio Bernardini, in Versilia. 
Se già Gaber si era chiesto se Faber fosse “liberale o extraparlamentare”, Guccini fu tagliente: “Colleghi cantautori, eletta schiera, che si vende alla sera per un po’ di milioni” – alludendo poi, nello stesso LP, a Marinella, che ormai faceva “la vita in balera”. De Andrè spiegò al settimanale Bolero che voleva fare abbastanza serate da guadagnare 300 milioni di lire e costruirsi uno studio alle Maldive. A Ciao 2001 disse invece: «Non mi vergogno di chiedere cachet consumistici per cantare in locali consumistici». Poi, a Oggi confessò che doveva pagare la nuova, grande tenuta in Gallura.
Sul piano personale, negli anni 70 mostrò il lato oscuro del suo carattere. Che non era mai stato squisito: pressoché alcolizzato dal 1958 al 1985 («una-due bottiglie di whisky al giorno», precisò). Un tantino peso sul piano sentimentale «Ho tradito mia moglie. Ma è come se non l’avessi mai fatto. E lei lo sa» (Bolero, 1971) «In Gallura io e Dori dormiamo in camere separate, così io posso andare a letto alle 4 di notte (…) Il matrimonio porta alcune delusioni. Ma tra noi c’è grande tolleranza reciproca. Penso sia già molto». (Specchio, 1990). Quasi nietzschanamente senza freni nel comportamento: a Sorrisi e Canzoni nel 1978 raccontò di quando tirava «merda di piccione nelle pentole della massaia del piano di sotto» e di come si era tolto la verginità a 11 anni con una capra.
Violento, come quando da ragazzo buttò la madre contro un vetro, e anche vedendola sanguinare si fece menare dal padre piuttosto che chiederle scusa. Greve col prossimo, come da aneddoto di Paolo Villaggio sull’automobilista che lo aiuta dopo un incidente, e per tutta gratitudine ottiene un’obiezione sul suo alito: «Ma lei ha mangiato della merda! Paolo, ma che cazzo ci facciamo qui con questo?».
Ma alla fine degli anni 70, una rigenerazione partì nel modo più brutale. Il sequestro fu una prova terribile: ammise poi di essere crollato, e di essersi appoggiato a Dori Ghezzi, tenendo però sempre nascosta una latta di tonno per tagliarsi le vene.
Sorvegliati da un metro, incappucciati, incatenati, i dialoghi rarefatti, al freddo, su frasche e sterpi, senza riparo dalla pioggia, con l’opportunità di far l’amore ogni tanto in modo più disperato che amoroso, si ritrovò sottomesso (parole sue, a Gente, 1980) ai rapitori, mentre Dori li mandava affanculo. Confessò poi di aver modificato in quel periodo il proprio rigido ateismo. Di sicuro, tornò con le idee molto più chiare, perché «Uno capisce quali sono i veri valori della vita». Il nuovo De André rimproverava al Manifesto di non occuparsi veramente dei sottoproletari, e porgeva l’altra guancia a chiunque, anche ai suoi rapitori. E quanto all’essere prodotto di consumo, obiettava: «Bisogna vedere se vendiamo carne fresca o carne marcia. Viaggiamo in un’economia capitalistica e speriamo che il fottuto capitalismo regga finché non ci sarà qualcosa di nuovo o diverso». E basta snobismo: «Presentiamoci anche noi cantautori a Sanremo come concorrenti, per far conoscere una canzone italiana diversa». 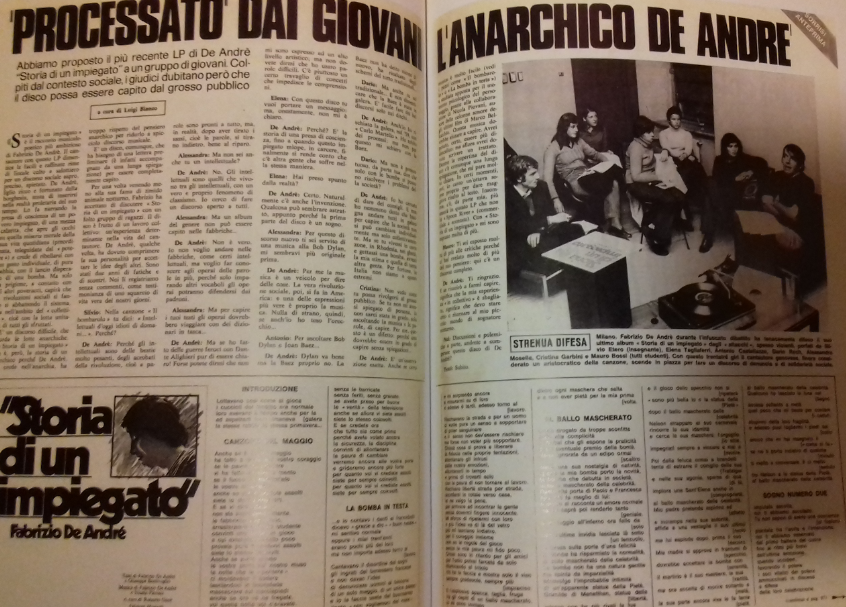
Negli anni 90 spezzò persino una lancia per il governo Berlusconi: «È giusto che il governo faccia il suo mestiere. Mi rassicura che in questo governo di destra ci sia la Lega, un movimento sicuramente democratico». Svelò un voto per Partito Sardo d’Azione e Sardigna Natzione.
Il cambiamento però fu soprattutto musicale. Gli stilemi cantautorali e il declamare intimidatorio, i medievalismi e le orchestrone lasciarono il posto a una visione finalmente contemporanea: l’immersione nel fiume etnico in cui nel 1984 ancora pochi si erano buttati (Peter Gabriel e David Byrne, ma va riconosciuto che da noi Demetrio Stratos, Battiato e il Battisti di Anima Latina c’erano arrivati anche prima di loro). «In Creuza de mà per la prima volta nella mia vita ho deciso di non fare il cantautore ma il cantante, mi sono preoccupato soprattutto dei suoni. Ho rinunciato al bel canto per cantare come u massacàn, il muratore. Prima, era innegabile l’influsso di Brassens, uno che non concedeva assolutamente nulla alla scena né alla confezione. Per fortuna Pagani mi ha impedito di fare la solita scansione metrica brassensiana, rompicoglioni, tedesca se vogliamo». 
L’incontro con Mauro Pagani completava la rivoluzione avviata dalla Pfm. Racconta Franz Di Cioccio: «Si era ritirato, non voleva più vedere i suoi dischi messi in discussione, preferiva tori e vacche. Ma nel 1978 venne a sentirci a Nuoro. Ci vide in camerino, contenti dopo il concerto. Forse provò invidia. Penso avesse paura di invecchiare nel suo eremo sardo. Una volta mi disse: Mentre tutti facevano il 68, io stavo in casa». Parole di De André: «All’epoca ero tormentato da interrogativi sul mio ruolo, il mio lavoro, l’assenza di nuove motivazioni. La Pfm mi diede una spinta verso il futuro». Conferma Di Cioccio: «Non per tirarcela, ma per me da lì iniziò ad essere realmente intrigato dalla musica, mentre prima la scaricava su altri. Prima era cantautore nel senso classico, quasi purista del termine: i testi prima di tutto. I suoi primi fans reagirono male alla nostra collaborazione quasi come i fans di Dylan inorriditi vedendolo con la chitarra elettrica». 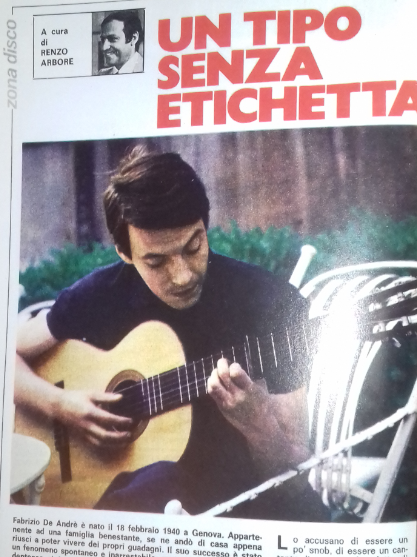
La Pfm (all’epoca i Quelli) putacaso, l’aveva portata via a Battisti. Proprio lui. Il suo completo opposto. «Quando ci fu proposto di suonare ne La Buona Novella, eravamo in soggezione, lui era più anziano di noi e già famoso. Noi all’epoca suonavamo nei dischi di Lucio, che era più della nostra generazione». Una strana condivisione, quella dei Quelli, perché proprio tra Battisti e De André si consuma lo scisma della musica italiana, la divisione tra i fautori della prevalenza del testo (ovviamente, schierati a sinistra) e quelli della musica (visti come destrorsi, come il “fascio” Battisti). Se De André era un contenitore per le scelte musicali di chi si trovava lì al momento (Reverberi, Bubola, Pfm, Pagani, Fossati…), Battisti era un contenitore musicale per i testi di Mogol e poi di Panella. Tra i due c’era poco amore. Battisti, nel 1970 ribadì a Oggi una sentenza già di Giorgio Gaber («le sue canzoni sono temini da liceali») rincarando: «Trovo i suoi testi interessanti, ma piuttosto goliardici, dato che piacciono solo agli studentelli. La parte musicale poi è solo accompagnamento, mentre io trovo che la musica debba avere sempre il ruolo principale nelle canzoni. Io più che gli italiani ascolto Bob Dylan, Ray Charles, Otis Redding, i Beatles, Donovan, i Led Zeppelin». Un anno dopo, ad Amica, De André obiettò che la musica italiana non doveva subire l’influenza anglosassone, e che Lucio Battisti era un ottimo musicista e molto all’avanguardia, «ma in fondo ricalcava gli esempi di James Brown e Joe Cocker». Va tenuto conto che De André, di solito aveva una parola buona e sincera curiosità per tutti i colleghi: doveva proprio soffrirlo. In ogni caso, per lui niente Led Zeppelin ma medioevo a go-go, a causa di «un professore che al liceo ci aveva presentato quel periodo come il migliore della Storia». 
E parlando di musica. Il primo De André, pur irresistibile per gli amanti del vintage, suona datato, conservatore rispetto alle spinte moderniste del rock internazionale dell’epoca; quando poi la buttava in madrigale, dando di gomito a una generazione di iscritti alla Facoltà di Lettere, viene la tentazione di chiedersi se con la sua influenza abbia appiattito la voglia di ricerca e istinto nella musica italiana. Del rock, o in genere delle novità, a lungo ebbe timore, lo si può dedurre da quanto ci dice Massimo Bubola: «A differenza sua ero un chitarrista elettrico e rappresentavo un mondo di cui aveva un po’ di paura perché incognito. Non amava certo gli Stones, ma gli chansonnier francesi… Ancor oggi qualche giornalista mi chiede quanto Faber mi abbia influenzato, ma penso sia stato il contrario». Finardi invece era stato cercato da De André perché gli facesse da robusta (anche fisicamente) spalla rock militante nella fase delle contestazioni ai cantautori, che lui tuttavia accettava autodenigrandosi (Roma, concerto al Palaeur: “Se hanno voglia di far casino è giusto che lo facciano, non ce n’è di cazzi”. O forse era l’ennesimo porgere l’altra guancia). «Lui era legato alla tradizione francese», ricorda Finardi, «Però in genere nei dischi lasciava spazio agli arrangiamenti di persone che avevano un’inclinazione per le colonna sonora orchestrale, in grande stile: Reverberi, Morricone, Piovani. Io ero in un’ala che ascoltava rock o anche fusion, i Weather Report, mentre lui, il rock credo non l’abbia mai realmente ascoltato. Così non parlavamo mai di musica, ma di politica. Lui era anarchico, io del PCI. Le nostre accese discussioni colpirono suo figlio Cristiano, che a 14 anni scappò di casa per venire da me, accusando Fabrizio di essere un borghese reazionario: lo chiamai e lo tranquillizzai. Politica a parte, eravamo in buoni rapporti. A lui piaceva chi lo affrontava, chi rispondeva alle provocazioni. Detestava essere trattato da sacra reliquia». 
Sacra reliquia? Ci conosceva bene, De André. E avrebbe sorriso del destino ridicolo di esser di tutti: di De Gregori come di Gabry Ponte, Frankie Hi-Nrg e Dolcenera, Fazio e Morgan, Beppe Grillo e Vincenzo Mollica, Paolo Villaggio e Fernanda Pivano. Di certo, ha saputo cogliere frammenti “di un mondo che avevamo nel cuore e non riuscivamo ad esprimere con le parole”. Ma che ora sono lì, dentro i suoi dischi, e tutto sommato dentro di noi. Se volete la controprova, controllate quanti frammenti sapete completare: “Dai diamanti non nasce niente…” “Si sa che la gente dà buoni consigli…” “Continuerai a farti scegliere…” “E’ stato meglio lasciarci che…” “Duve gh’è pei…” “Lo Stato che fa? Getta la spugna con…”. “Anche se vi credete assolti…”
Quindi, forse fu davvero piccolo borghese come diceva lui.
Ciononostante, questo è poco ma sicuro, per il pubblico la sua anima è salva.

Ciao, hai esagerato con l’autocritica, a me sembra un bel pezzo. Sui motivi per cui De André è facilmente manipolabile, sei sempre in tempo a scrivere altro.
Spero che ti venga voglia di farlo.
Mi associo al commento precedente. Il pezzo è davvero ottimo, non per voler fare il bastian contrario ma questo prostrarsi all’immaginetta sacra e senza difetti di un De Andrè che non esiste mi irrita oltremodo